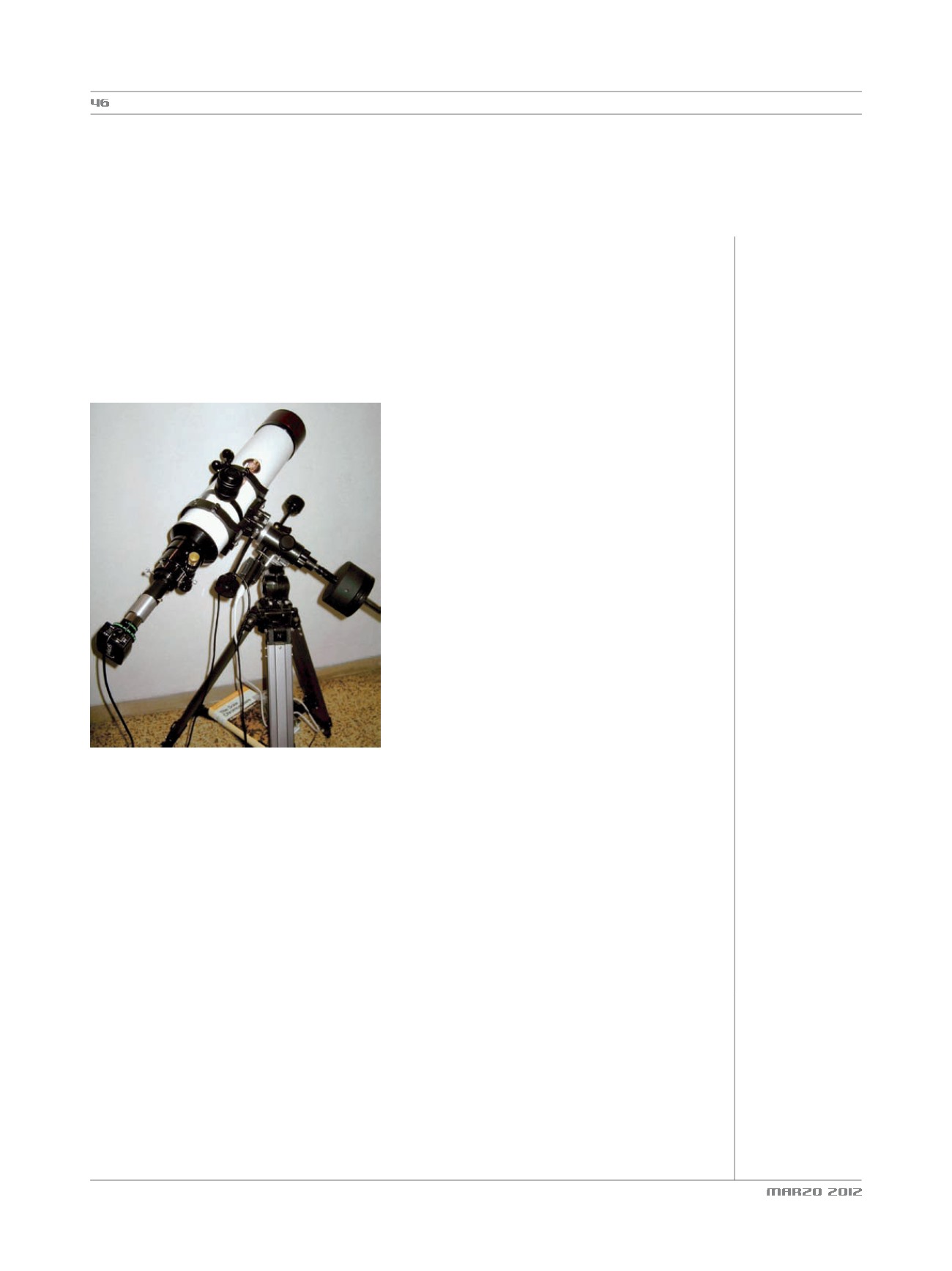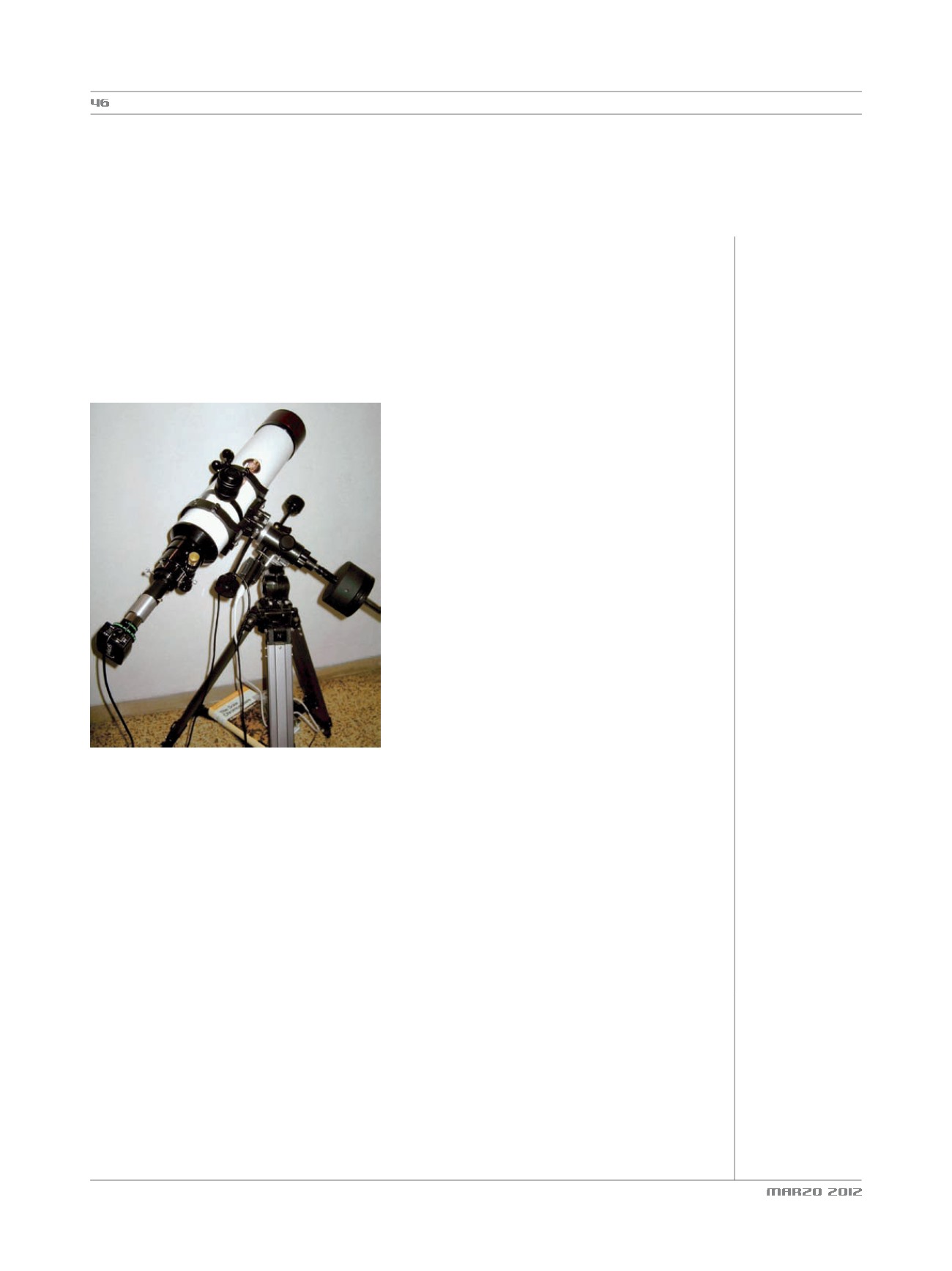
ASTROFOTOGRAFIA
ASTROFILO
l’
mera CCD da 4.4 micron. In questo caso la
focale ottimale massima da utilizzare con-
sigliata sarà di 3060 mm (un fattore circa
1.11 maggiore di quella teorica in luce mo-
nocromatica) con campionamento effet-
tivo di 0.18”/px e quindi si potrà utilizzare
un sistema moltiplicatore di focale fino a
4x, con lo strumento indicato. Natural-
mente queste sono considerazioni teori-
che, valide solo in condizioni ottimali; nella
pratica il vero limite lo impone il seeing
che quasi sempre degrada la qualità del-
l’immagine anche a focali medie. Conviene
utilizzare sempre valori delle focali che ri-
sultano compatibili con il seeing locale. So-
lamente nelle rare condizioni di seeing
ottimale, con un’immagine priva di “blur-
ring” (letteralmente annebbiamento, sfo-
catura), cioè un’immagine in movimento e
distorta ma sempre ben a fuoco con i det-
tagli fini visibilmente stabili (senza l’effetto
di sfocatura dovuto alla turbolenza), si
potrà spingere lo strumento alle focali li-
mite indicate dalle formule. Le tecniche di
elaborazione delle immagini riescono in-
fatti a compensare abbastanza bene le
componenti di distorsione e di movimento
del see-ing, ma non riescono a correggere
gli effetti di sfocatura dovuti alla compo-
nente di blurring, la cui ampiezza dipende
dal quadrato della focale dello strumento,
a parità di condizioni atmosferiche. Questo
comporta che un buon osservatore solare
sperimenti, per un dato luogo di osserva-
zione, quali sono i momenti migliori (in
termini di seeing) per riprendere in alta ri-
soluzione il Sole. Non esiste infatti una re-
gola generale che valga per tutti i luoghi e
per ogni periodo dell’anno: bisogna verifi-
care in modo empirico in quale momento
del giorno, in un dato periodo dell’anno, è
opportuno fare le riprese solari, minimiz-
zando gli effetti del seeing locale.
Per la scelta della focale vale, in conclu-
sione, sempre la regola generale: è meglio
una immagine ben definita, ricca di detta-
gli a grande scala che un’immagine con-
fusa e sfocata a piccola scala.
n
L
a strumentazione utilizzata dall’autore per
riprendere le due immagini di pagina 44: ri-
frattore 102/714 con filtro H-
α
e camera CCD.
che per seeing si intende il fenomeno di de-
terioramento dell’immagine di una sor-
gente astronomica la cui radiazione,
attraversando l’atmosfera prima di giun-
gere a noi, subisce l’effetto dei moti casuali
delle celle d’aria che si trovano a differenti
temperature e densità, variandone l’indice
di rifrazione e provocando così la distor-
sione, lo spostamento e il deterioramento
casuale del fascio di luce rilevato (U. Gros-
smann-Doerth, 1969). Si sarà già capito che
la formula teorica per la risoluzione di-
pende anche dalla lunghezza d’onda della
radiazione osservata. Nel caso di osserva-
zioni in luce monocromatica nella banda
H
α
,
λ
= 656.28 nm, la risoluzione R aumenta
di un fattore 1.15 e quindi anche il campio-
namento, riducendo la focale ottimale.
D’altra parte, i fotografi esperti in luce mo-
nocromatica sanno dall’esperienza pratica
che è bene come norma generale non spin-
gere lo strumento sopra al rapporto empi-
rico f/30 (rapporto tra focale e diametro
dello strumento), per non incorrere in una
degradazione eccessiva dell’immagine mo-
nocromatica che impedisce da un lato una
precisa messa a fuoco e dall’altro esalta i di-
fetti e le limitazioni dell’ottica e del sen-
sore. Supponiamo quindi di utilizzare uno
strumento dedicato in H
α
aperto a f/7
(D=102 mm, F=714 mm) e di utilizzare la ca-