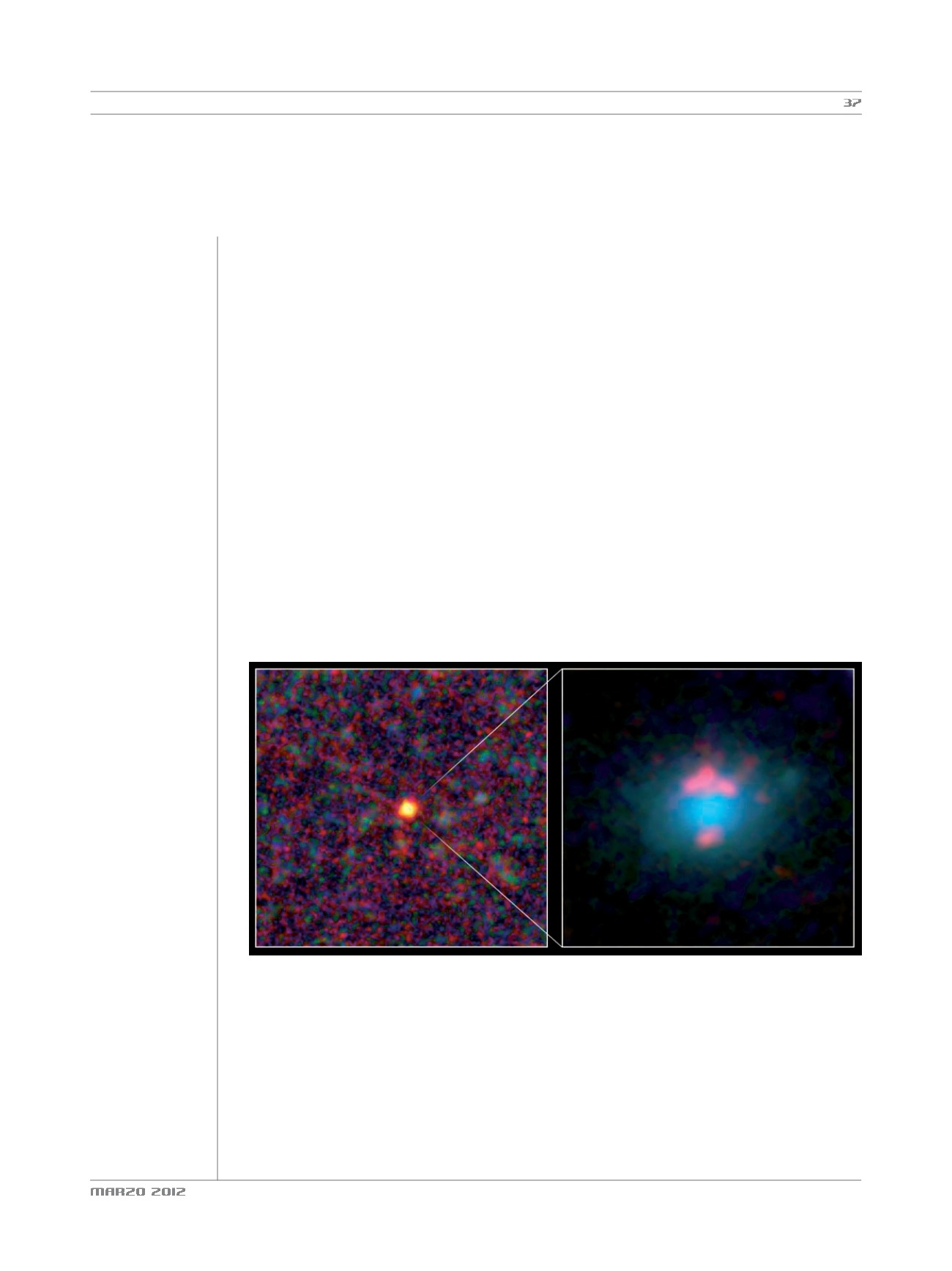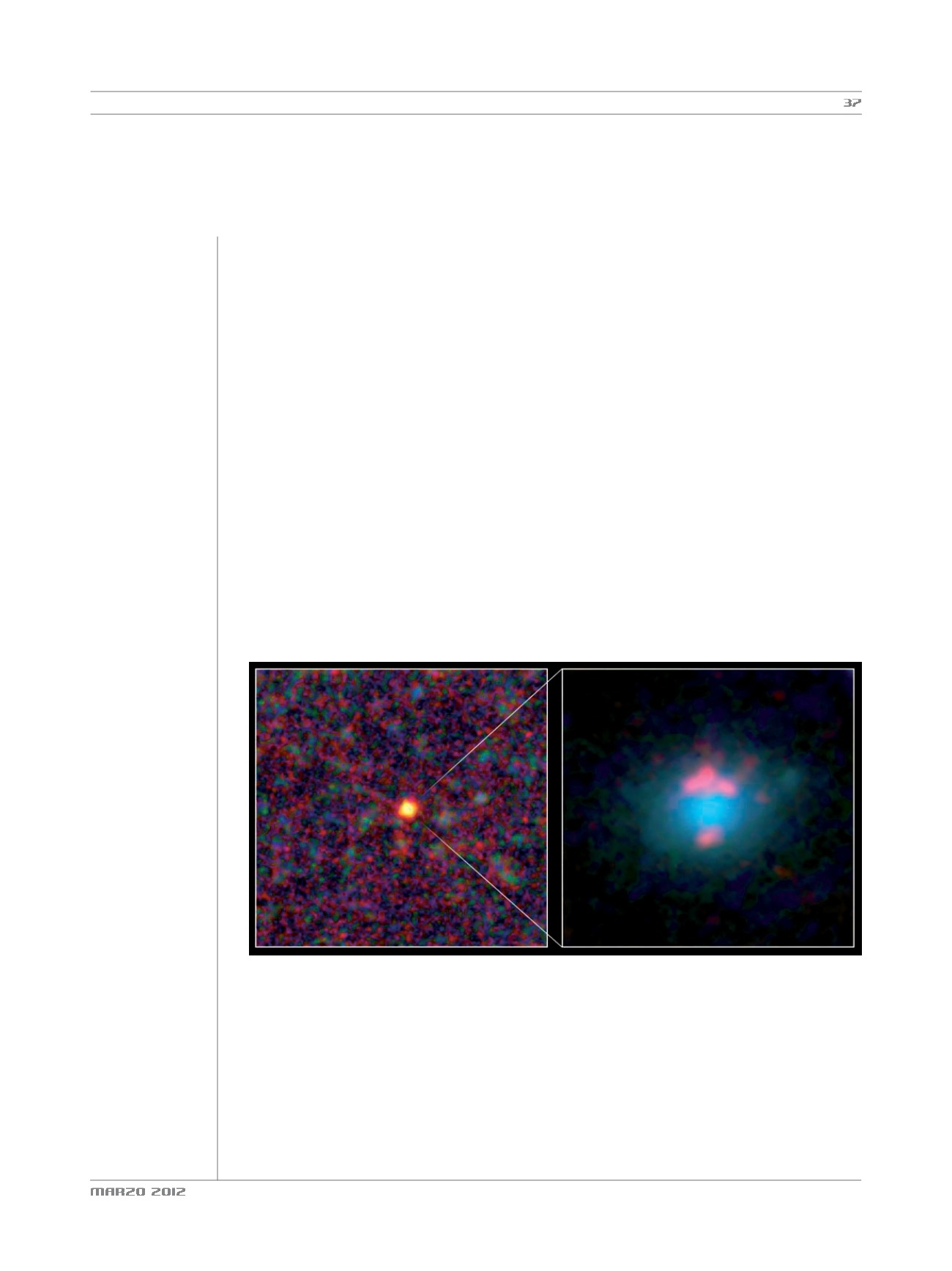
ASTROFILO
l’
GALASSIE
D
i recente, astronomi dell’Harvard-Smi-
thsonian Center for Astrophysics (CfA)
hanno utilizzato lo strumento IRAC a
bordo dell’osservatorio spaziale infrarosso
Spitzer per scoprire quattro galassie che ap-
paiono insolitamente rosse. Sono talmente
rosse che riprodurre i loro colori con i modelli
richiede valori di età, massa ed estinzione
della polvere così estremi da far pensare che
i correnti modelli sull’evoluzione delle galas-
sie possano essere sbagliati.
Ma cominciamo col chiarire che cosa inten-
diamo quando in astronomia definiamo un
oggetto “rosso”. I sensori attraverso i quali
vengono riprese le immagini di galassie lon-
tane sono monocromatici, quindi diversi da
quelli delle più familiari camere digitali che
catturano i colori automaticamente. Qualun-
que astrofotografo abbastanza serio sa che
devono essere usati dei filtri per registrare i
colori quando si usano sensori specifici per
astronomia. Se un oggetto è rosso, l’imma-
gine monocromatica apparirà più brillante
attraverso un filtro rosso che non attraverso
un filtro blu, cosicché i colori potranno essere
assegnati successivamente, quando i vari ca-
nali saranno combinati via software. Le im-
magini a colori sono tipicamente la somma
di immagini ottenute tramite filtri rossi, verdi
e blu, il che equivale a riprodurre i principali
colori visibili all’occhio umano.
Gli astronomi estendono il concetto di colore
oltre le lunghezze d’onda alle quali possiamo
realmente vedere i colori, pertanto, un og-
getto che appare più brillante alla lunghez-
za d’onda di 2 micron che non a quella di 1
micron è definito “rosso”. Il tutto è abba-
stanza intuibile e il descrivere gli oggetti
come “rossi” o “blu” facendo riferimento a
una specifica coppia di lunghezze d’onda o
di filtri è un modo semplice per comparare
quegli stessi oggetti; un’utile sintesi in un
campo già stracolmo di termini ottusi.
Nel caso delle quattro galassie estrema-
mente rosse scoperte da Spitrzer stiamo
considerando lunghezze d’onda collocate
nel range del vicino e medio infrarosso,
esattamente a 1.65 e 4.5 micron (entrambe
oltre la visione umana). A queste lunghezze
d’onda il Sole, ad esempio, che ha il suo
picco di emissione nel visibile, ha una lumi-
nosità che cade vertiginosamente passando
da 1.65 a 4.5 micron, rendendolo “blu” in
questi filtri. La luce proveniente da una ga-
lassia normale altro non è che la somma di
miliardi di stelle con diverse temperature, e
anch’esse tendono a essere più deboli a 4.5
micron che non a 1.65 micron.
Allora perché c’è così tanto clamore per la
scoperta di alcune galassie estremamente
rosse? I vari effetti che possono agire per ren-
dere le galassie “rosse” in quelle lunghezze
d’onda sono al cuore del perché oggetti
molto rossi attirano l’interesse dei ricercatori.
Il primo effetto è semplicemente il redshift
della sorgente. La velocità di recessione per
una sorgente molto distante sposterà l’emis-
sione di una galassia verso il rosso. È interes-
A
sinistra sono
evidenziate
28 galassie parti-
colarmente rosse
appartenenti
all’universo con
età inferiore al
miliardo di anni.
[NASA, ESA, R.
Bouwens and G.
Illingworth (Uni-
versity of Cali-
fornia, Santa
Cruz, USA)]
L
a forte compo-
nente rossa
nella luce di ga-
lassie lontane può
essere messa in
evidenza anche
attraverso il feno-
meno delle lenti
gravitazionali. Nel
riquadro di sini-
stra, una galassia
ripresa con il tele-
scopio spaziale
Herschel (IR); in
quello di destra,
la stessa galassia
ripresa in maggior
dettaglio in luce
visibile e blu, con
sovrapposizione
di luce submilli-
metrica e rossa.
[ESA/NASA, JPL-
Caltech, Keck/SMA]