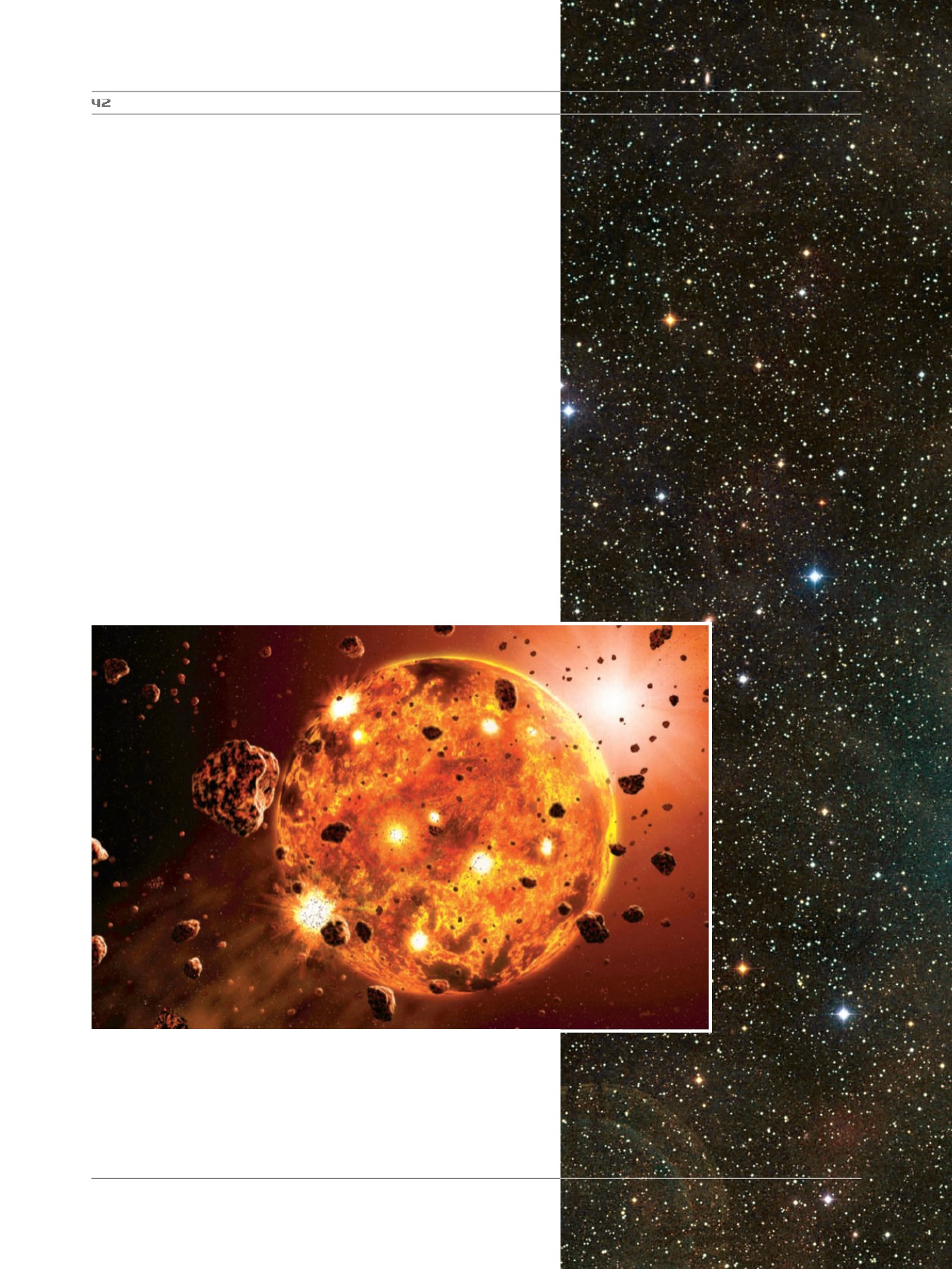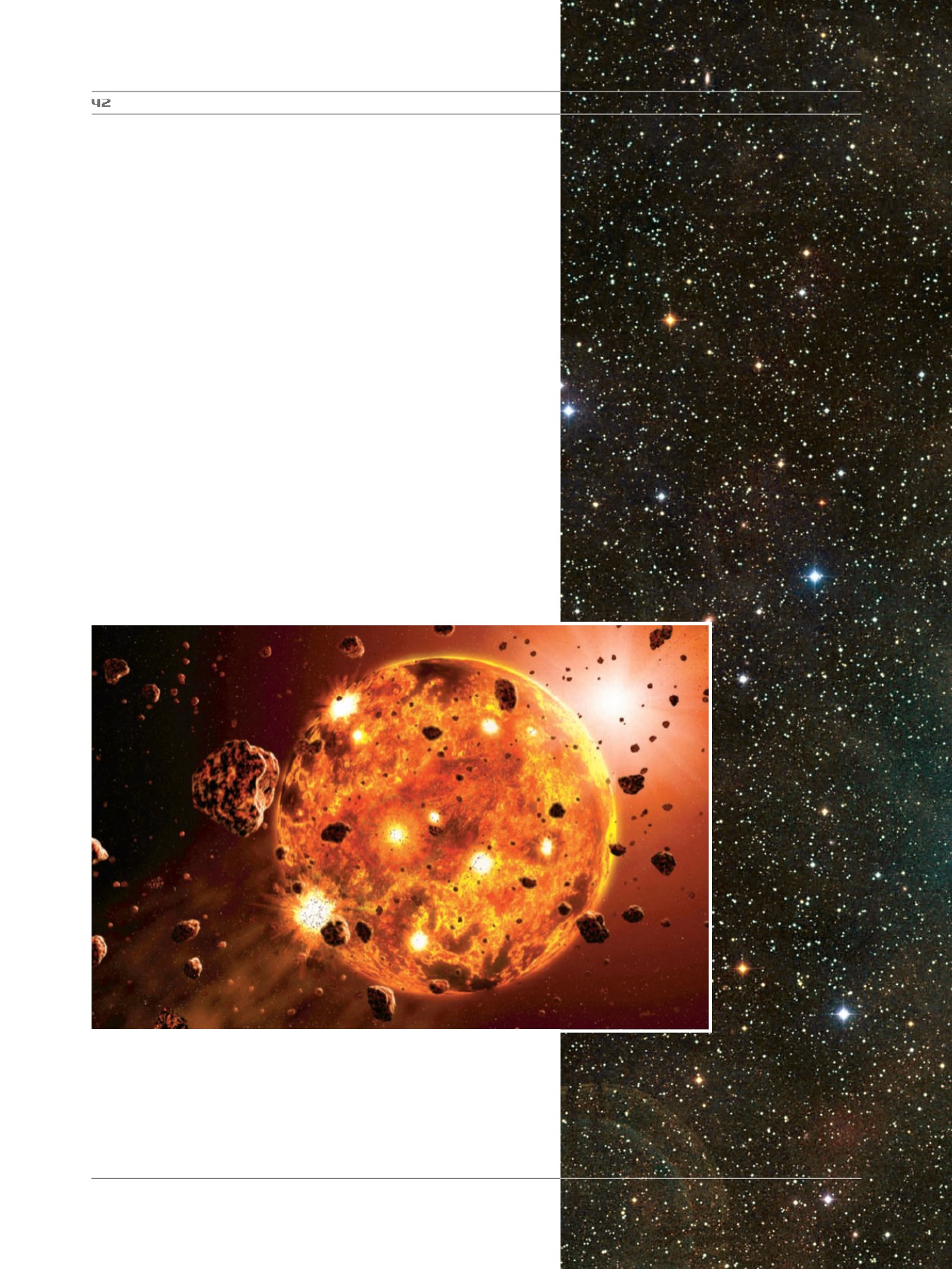
GENNAIO-FEBBRAIO 2015
PLANETOLOGIA
ASTROFILO
l’
ottici operanti in luce bianca, mentre nei telescopi infrarossi lascia
intravedere scenari per lo più indistinti. Oggi, però, ALMA offre op-
portunità di ricerca prima impensabili e questo principalmente per
due buoni motivi. Uno è relativo alle lunghezze d'onda raggiungi-
bili, che sono compatibili con ambienti più freddi di quelli raggiun-
gibili con telescopi più tradizionali, e i dischi protoplanetari sono
ambienti decisamente freddi (poche decine di kelvin). L'altro buon
motivo è legato all'altissima risoluzione angolare delle immagini ot-
tenibili con ALMA, sfruttando i principi dell'interferometria, per i
quali più lontani sono fra loro i singoli elementi di una rete di tele-
scopi o radiotelescopi, più elevato sarà il potere risolutivo risultante
(e più difficile sarà sovrapporre costruttivamente i diversi segnali ac-
quisiti). Le 66 di antenne di ALMA possono essere disposte su un'a-
rea ampia fino a 16 km, che per quanto concerne la risoluzione e-
quivale a utilizzare un'unica antenna di quel diametro. Per con-
fronto si consideri che altri strumenti simili che operano a lunghezze
d'onda millimetriche hanno antenne che possono essere separate
al massimo di un paio di chilometri.
Lo scorso settembre ALMA ha iniziato un periodo di test con acqui-
sizione di immagini su una base ampia 15 km, quindi vicina al mas-
simo consentito, e i risultati non si sono fatti attendere. Lo strumento
ha infatti prodotto quella che gli astronomi considerano la migliore
L
’illustrazione qui sopra rende l’idea di come avviene l’accrescimento dei
corpi solidi all’interno dei dischi protoplanetari: da semplici conglomerati
di granelli simili alla sabbia si arriva a oggetti di taglia planetaria. A destra,
la grande regione nebulare della costellazione del Toro, nella quale è nata
meno di 1 milione di anni fa la stella HL Tauri (indicata dalla freccia) col suo
disco protoplanetario. [Alan Brandon/Nature, ESO/Digitized Sky Survey 2]