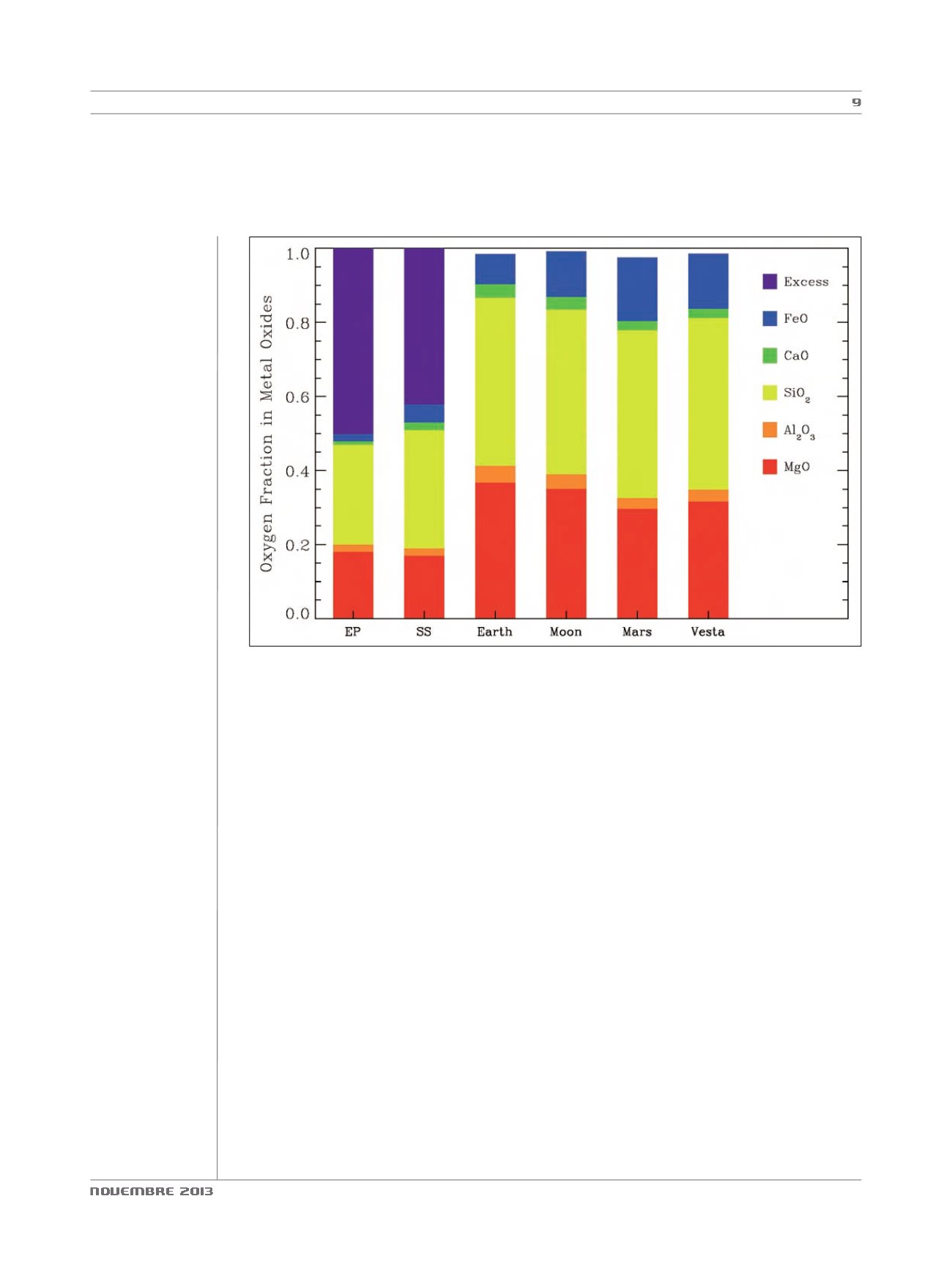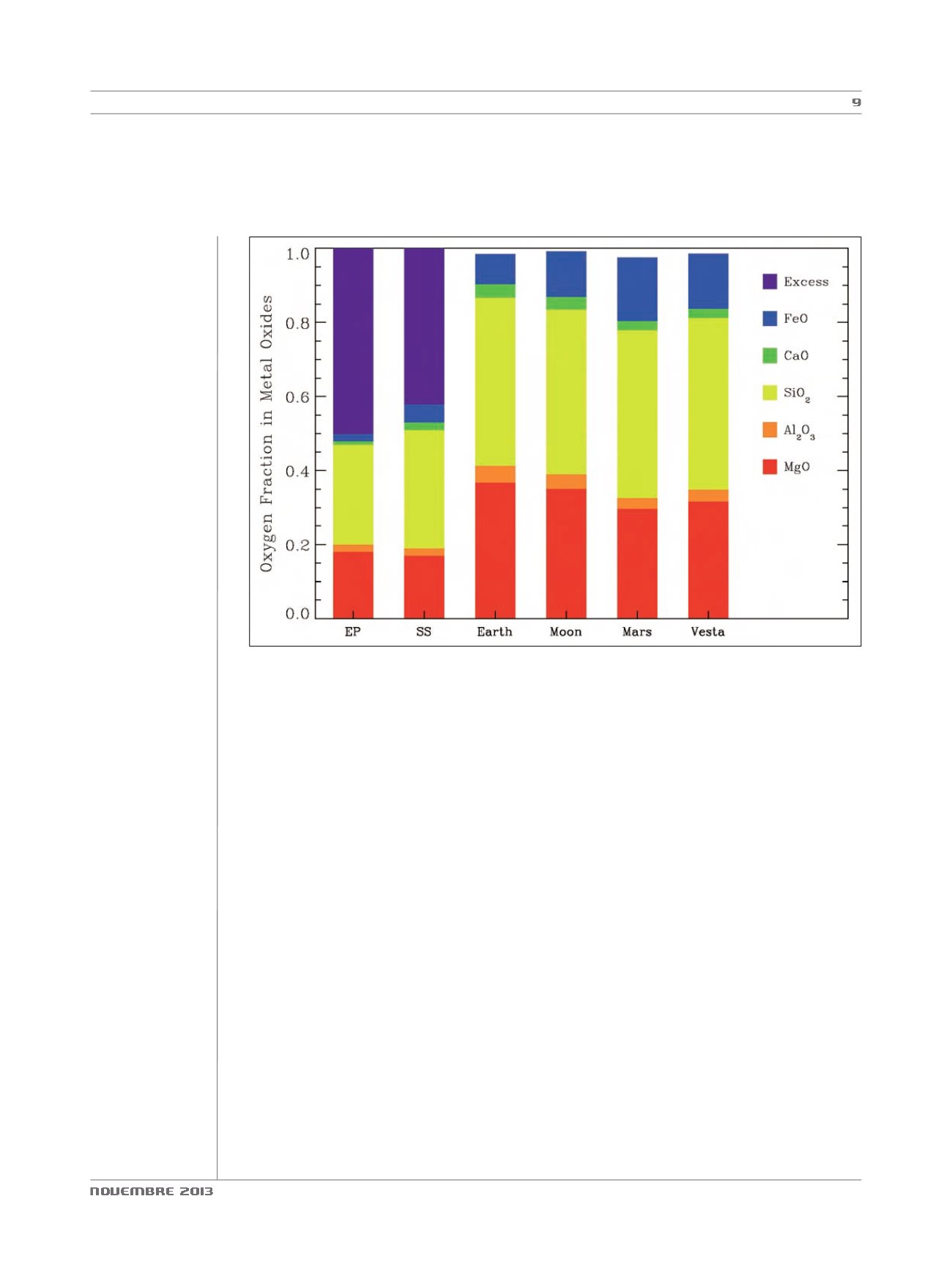
CORPI MINORI
ASTROFILO
l’
L
e prime due
colonne di
questo diagram-
ma mostrano in
viola le frazioni
di ossigeno libero
attese sulla su-
perficie di GD 61
nei casi in cui il
trasferimento sia
all’inizio (EP) o in
una fase interme-
dia stabile (SS).
Le altre colonne
indicano la com-
posizione di cro-
sta e mantello di
Terra, Luna, Mar-
te e Vesta. Nes-
suno di questi
corpi mostra ec-
cessi di ossigeno
libero, mentre ne
hanno frazioni
maggiori legate
ad altri elementi.
[J. Farihi et al.]
sferico di idrogeno sufficiente a dar conto
del primo come sottoprodotto della rottura
delle molecole di acqua; l'ossigeno deve co-
munque superare quello atteso dalla rot-
tura dei composti diversi dall'acqua che
concorre a formare; deve infine esistere un
disco circumstellare di detriti derivante da
un corpo roccioso disgregato. La presenza
di quest'ultimo è determinante perché ga-
rantisce che l'inquinamento degli strati più
esterni della nana è ancora in corso e non
può che avere in quel disco la sua causa, il
che, tramite opportuni modelli matematici,
permette di stimare le abbondanze attese
dei vari elementi e quindi di rilevare un
eventuale eccesso di ossigeno riferibile al
corpo progenitore.
Negli ultimi anni sono stati scoperti attorno
a una trentina di nane bianche altrettanti
dischi di detriti, molto probabilmente pro-
dotti dalla distruzione mareale di asteroidi.
Fra tutti i sistemi, l'unico che soddisfa i re-
quisiti di cui sopra è quello di GD 61 e da un
recente lavoro condotto dai tre ricercatori
cui si accennava all’inizio e che rispondono
ai nomi di Jay Farihi (University of Cam-
bridge), Boris Gänsicke (University of War-
wick) e Detlev Koester (University of Kiel) è
risultato che nel caso di quella nana l'ec-
cesso di ossigeno è così rilevante che non
meno del 26% della massa dell'asteroide di-
strutto doveva essere costituita di acqua
(per confronto, sulla Terra c'è in propor-
zione mille volte meno acqua).
I tre ricercatori hanno analizzato la luce di
GD 61 sia nell'ultravioletto sia nel visibile,
utilizzando dati spettroscopici raccolti col te-
lescopio spaziale Hubble e con uno dei due
telescopi Keck delle Hawaii. Con quel tipo di
osservazioni è stato possibile stimare le ab-
bondanze relative di una serie di elementi
che si legano facilmente all'ossigeno, ossia
magnesio, alluminio, silicio, calcio e ferro,
che formano MgO, Al
2
O
3
, SiO
2
, CaO e FeO.
Anche considerando le massime quantità di
ossigeno che avrebbero potuto liberarsi da
tali molecole e l'apporto di ossigeno mole-
colare, questo elemento rivelatore continua
a presentarsi in quantità tale che per spie-
garne l'origine non si può che ricorrere alla
rottura delle molecole dell'acqua. (Da no-
tare che nel budget dell'ossigeno non è
stato considerato l'eventuale apporto della
CO
2
, dal momento che la presenza del car-
bonio negli spettri di GD 61 è trascurabile,
cosa che avalla la natura asteroidale e non