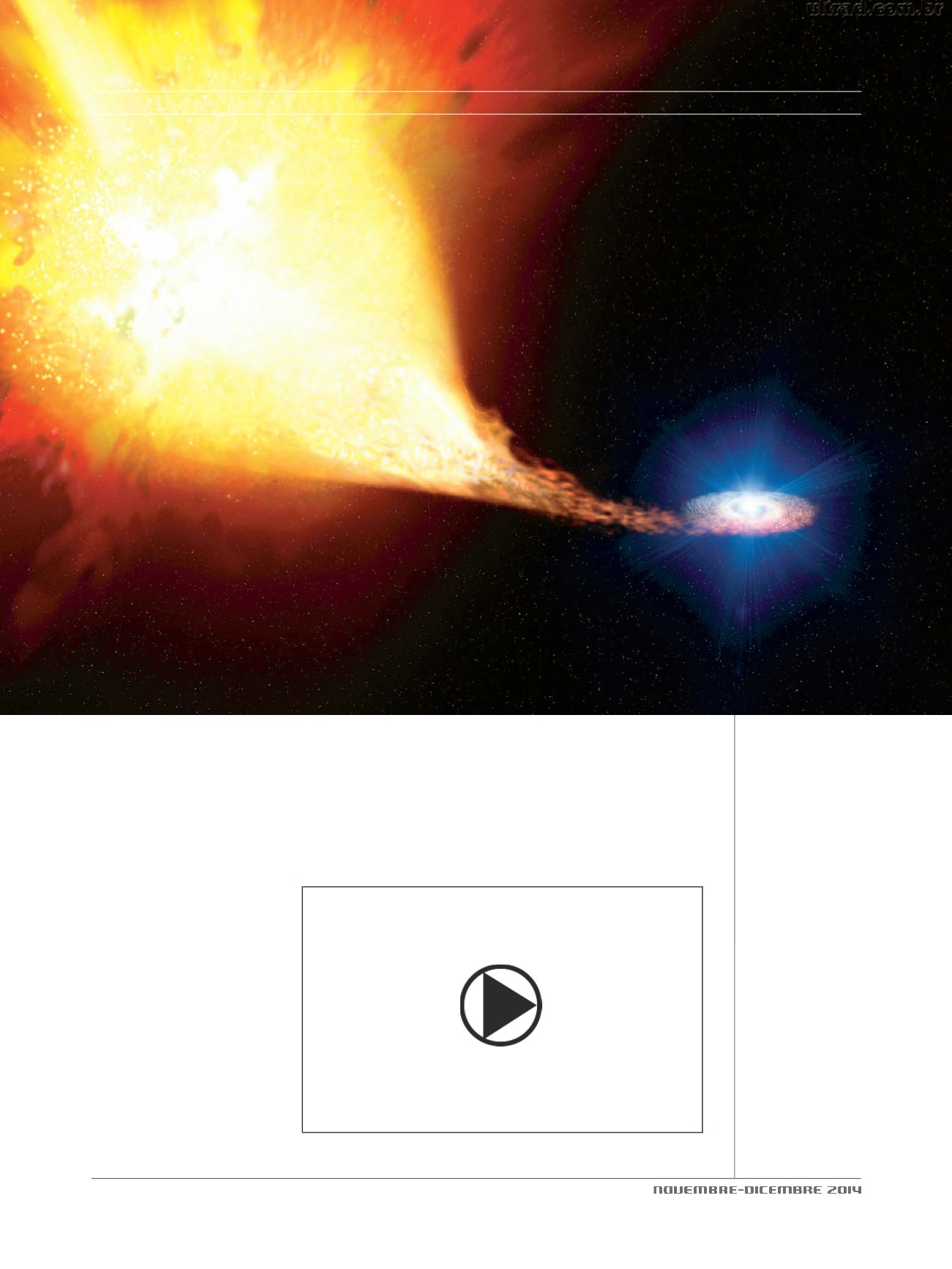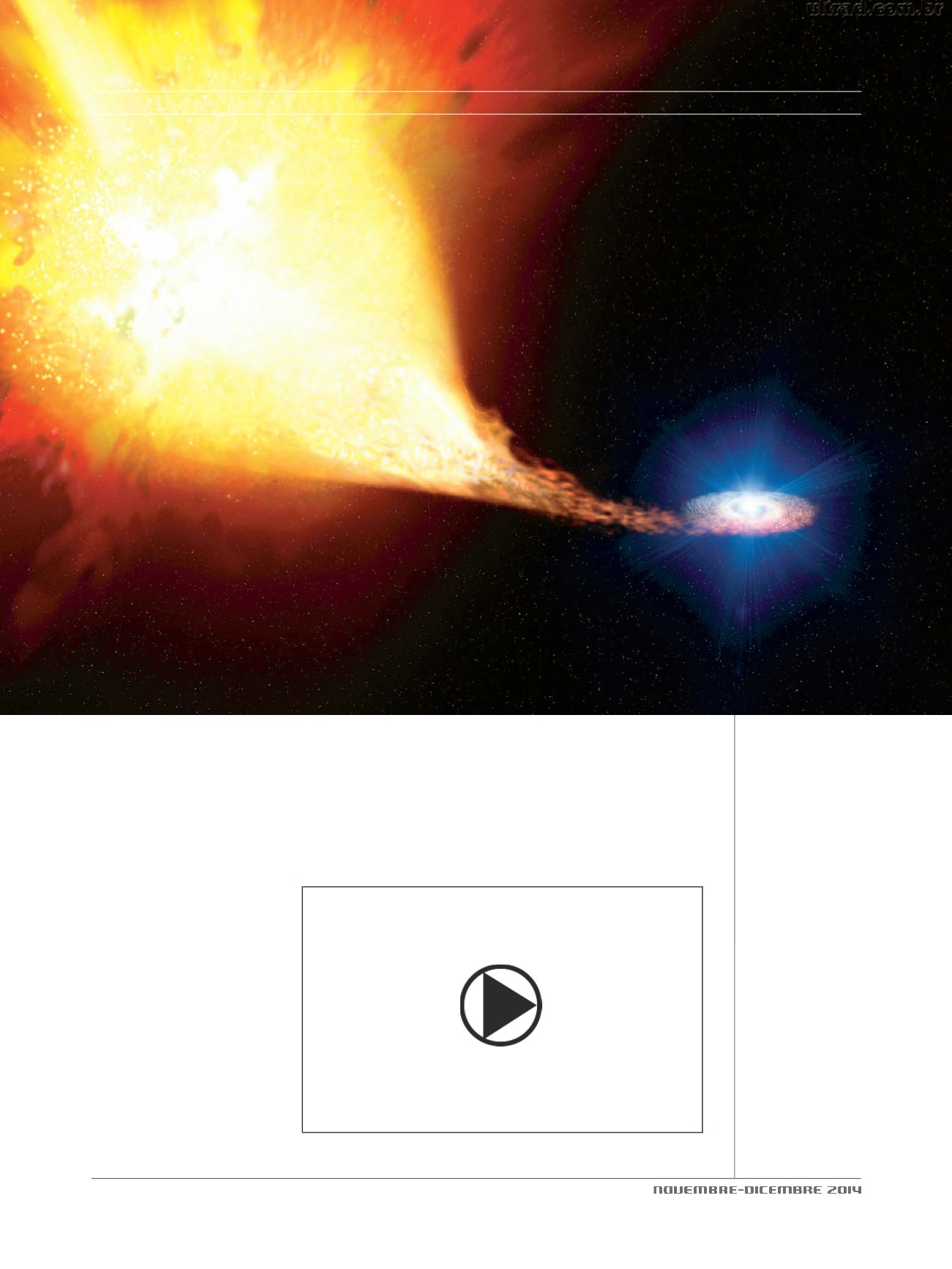
28
SUPERNOVAE
ASTROFILO
l’
sua luce nei mesi successivi all'esplosione,
elemento che diviene via via sempre più ra-
refatto (e quindi meno rilevabile) a causa
dell'espansione del residuo di supernova.
Contemporaneamente inizia invece ad ab-
bondare l'elio, chiara indicazione del fatto
che il progenitore aveva precedentemente
perso gli strati più esterni, nei quali domina
l'idrogeno. Ciò non accade in una classica su-
pernova di Tipo
II
, dove l'idro-
geno rimane facilmente rile-
vabile per lungo tempo. Per-
ché questa differenza? Qual è
il meccanismo che sottrae ai
progenitori del Tipo
II
b gli
strati esterni di idrogeno? Gli
astronomi si sono posti queste
domande sin dalle prime sco-
perte di quella variante e le
possibili risposte sono venute
dal fronte teorico, con la co-
struzione di modelli concordi
su uno scenario che vede una
stella compagna strappare l'i-
drogeno al vicino progenitore della super-
nova. Quest'ultimo, giunto al termine della
sua esistenza, si espande come supergigante
rossa e i suoi strati più esterni ricchissimi di
idrogeno raggiungono la stella compagna
(meno massiccia e quindi ancora in “buona
salute”), la quale li risucchia attraverso il pun-
to di contatto dei due lobi di Roche (le “sfere”
d’influenza gravitazionale delle due stelle).
R
appresenta-
zione artistica
del sistema bina-
rio all’origine
della SN 1993J,
dove una super-
gigante rossa
giunta al termine
della sua esi-
stenza esplode
mentre la stella
compagna sta an-
cora sottraendo-
le gli strati più
esterni di idro-
geno. A fianco,
un video che illu-
stra più dettaglia-
tamente quel
medesimo scena-
rio. [ESA/Hubble
(M. Kornmesser &
L. L. Christensen)]