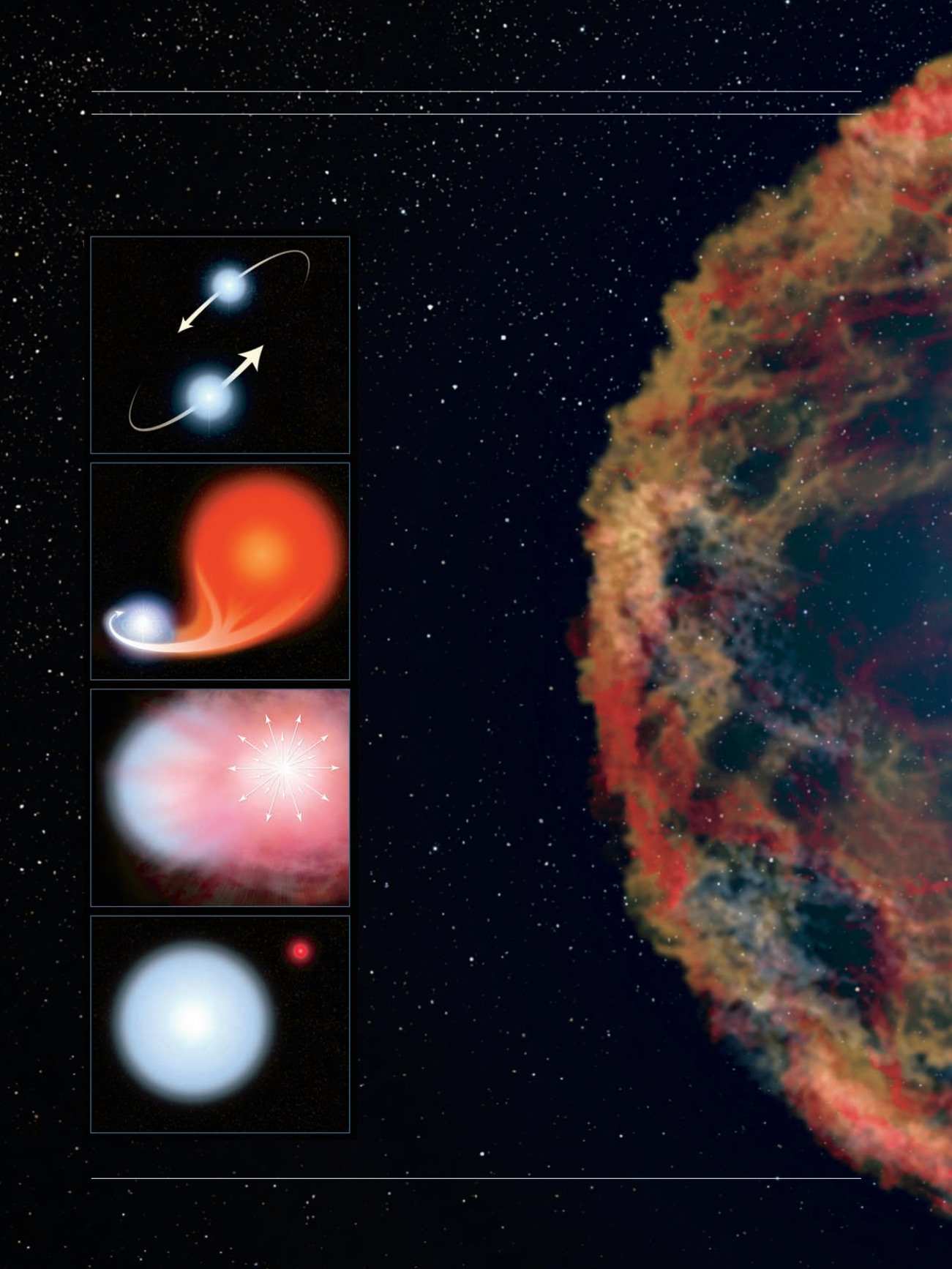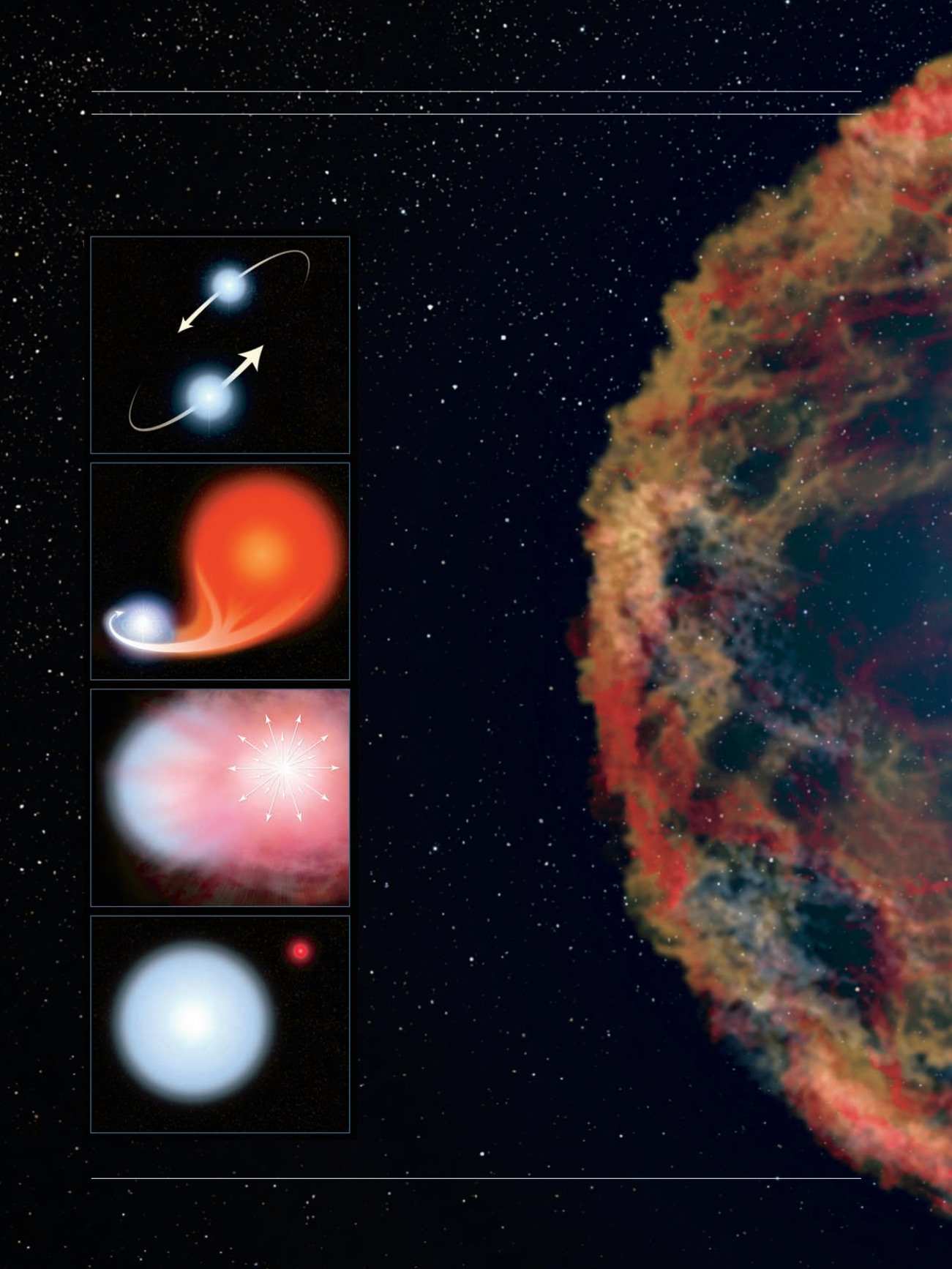
siano sufficientemente inde-
boliti da lasciar intravedere
le tracce spettrali dell'even-
tuale stella compagna, va
da sé che il miglior candi-
dato per una ricerca in tal
senso sia l'esplosione più
datata, quindi quella del-
la SN 1993J (scoperta il
28 marzo 1993 dall'astro-
filo spagnolo Francisco
Garcia). Oltre che per mo-
tivi temporali, quest'ul-
tima è un ottimo target
anche per via della sua
relativa vicinanza, essen-
do esplosa in M81, una
ben nota galassia dell'Or-
sa Maggiore, distante “so-
lamente” 11 milioni di anni
luce. È di fatto la più vicina
supernova di Tipo
II
b finora
osservata dagli astronomi e
la possibilità di scoprire la sua
stella compagna ha stimolato
diverse ricerche nell'ultimo ven-
tennio. Avendo gli astronomi i-
dentificato il progenitore della SN
1993J come supergigante di tipo
spettrale K (temperatura superficiale
non lontana dai 4000 kelvin), era stato
previsto che dal 2006 la radiazione pro-
veniente dal residuo dell'esplosione sa-
rebbe divenuta sufficientemente debole da
consentire di riconoscere il contributo della
stella compagna sotto forma di un eccesso di ra-
diazione ultravioletta. Un flusso di quel tipo, nor-
malmente atteso in presenza di una stella cal-
dissima, era già stato parzialmente rilevato nel
2002 e nel 2004 grazie a osservazioni condotte con
ASTROFILO
l’
SUPERNOVAE
NOVEMBRE-DICEMBRE 2014
30
E
cco, in sintesi, come si forma una supernova di
tipo
II
b: due stelle giganti orbitano attorno al
comune baricentro fin quando una di esse sot-
trae grandi quantità di idrogeno alla compa-
gna divenuta supergigante rossa. Quest’ul-
tima esplode lasciando un residuo compo-
sto prevalentemente di elio, elemento che
finisce col caratterizzare anche la stella su-
perstite. [NASA, ESA, and A. Feild (STScI)]
A piena pagina, una visione artistica del
residuo della SN 1993J. [NASA, ESA,
and G. Bacon (STScI)]