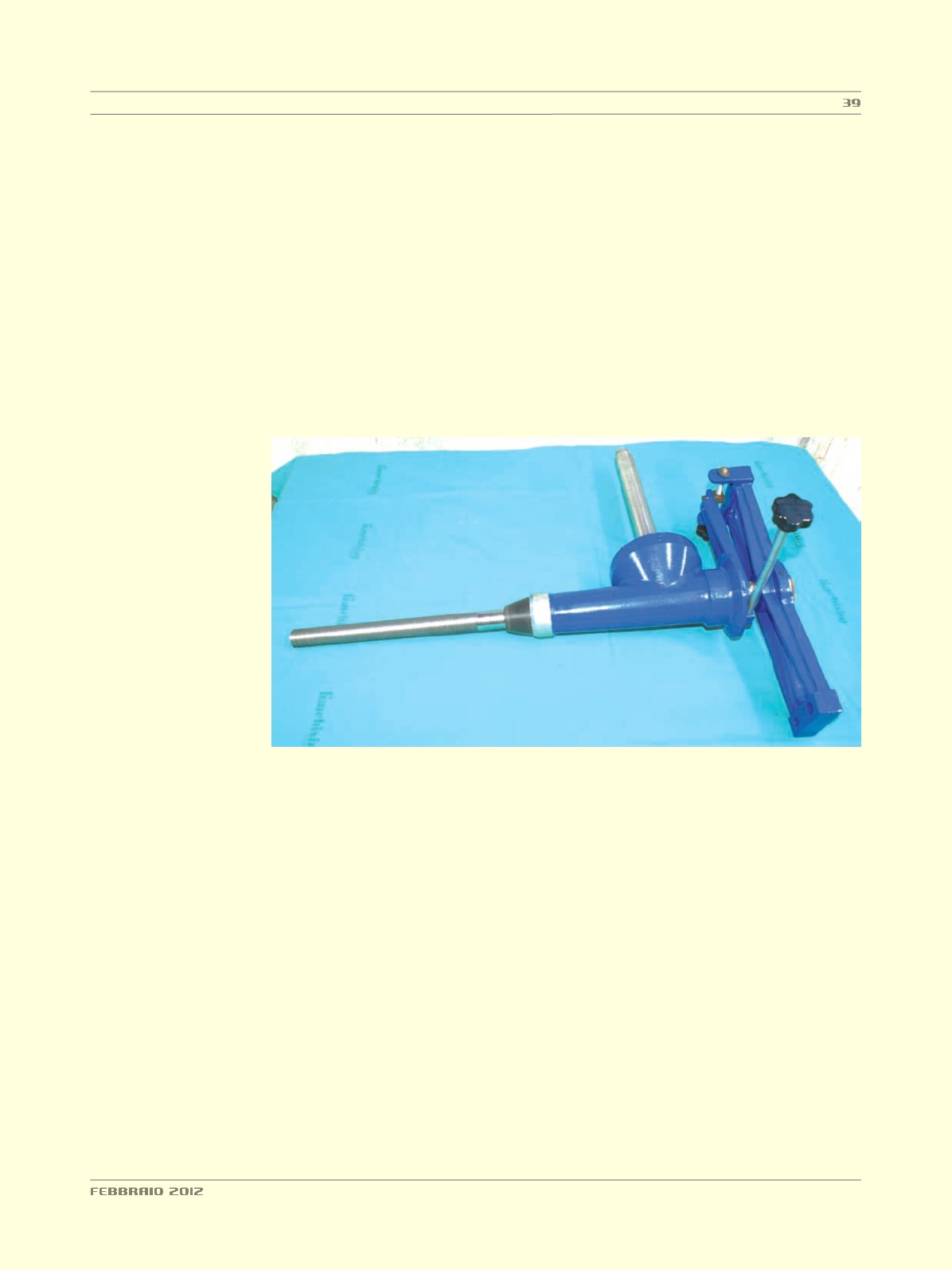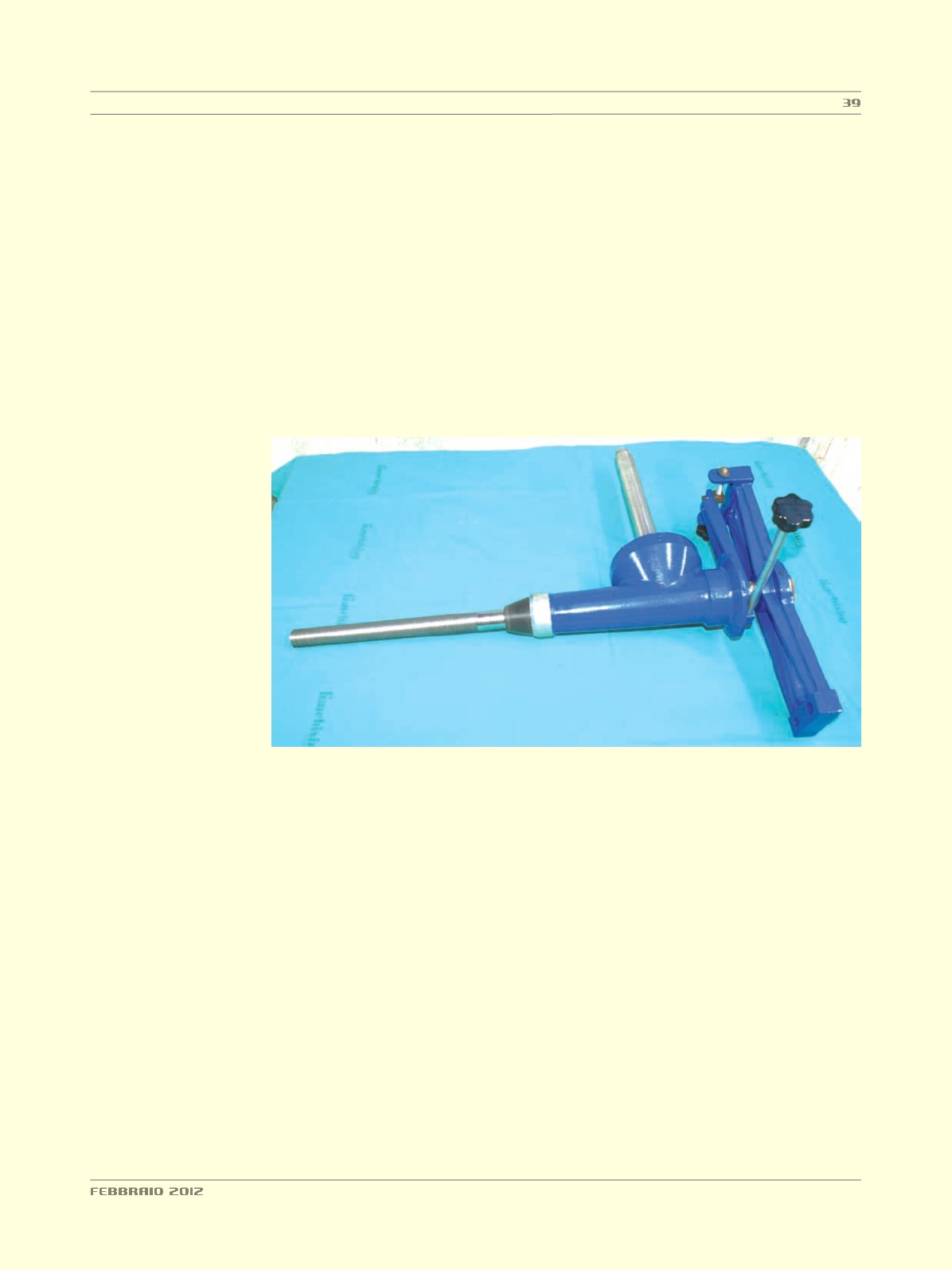
STRUMENTI
ASTROFILO
l’
nel mio laboratorio di Campobasso,
ho fotografato tutte le parti della
montatura; quindi l’ho smontata
completamente pezzo per pezzo in
modo da studiarne bene tutti i com-
ponenti. La montatura era costituita
essenzialmente di due assi in acciaio
C40 (da 30 mm di diametro l’asse di
declinazione e da 40 mm di diame-
tro l’asse orario), una fusione di allu-
minio con gli alloggiamenti per i
due cuscinetti dell’asse di declina-
zione, una seconda fusione con le
sedi dei due cuscinetti dell’asse ora-
rio, una terza fusione che univa
l’asse orario alla base della monta-
tura, consentendone la messa in po-
stazione (con semplice dispositivo a
vite in ottone per la regolazione
fine in altezza), una quarta fusione
che rappresentava il “trait d’union”
con la colonna, alta circa un metro,
con sezione di 170 mm, e infine tre
razze in fusione di alluminio, dotate
ciascuna di una vite in acciaio C40,
con manopola zigrinata in alluminio
e base di appoggio “orientabile”
grazie a una sfera di acciaio inserita
al suo interno; ciascuna razza era
dotata della sede per l’inserimento
di una ruota piroettante.
Il sistema di inseguimento in A.R.
era costituito da una corona den-
fusi a quei tempi, come ad esempio
il classico riflettorino 114/900 e si-
mili. Con montature come le Astro
Italia era già possibile iniziare a ci-
mentarsi con la fotografia a lunga
posa, che ai tempi veniva effettuata
con pellicole ipersensibilizzate e (so-
vente) inseguimento manuale con
l’occhio al telescopio di guida.
La montatura oggetto di questo re-
stauro era depositata in un capan-
none agricolo presso Latina; le parti
in acciaio erano completamente os-
sidate, la colonna in ferro e le fu-
sioni in alluminio erano state
probabilmente riverniciate alla
buona anni prima con un prodotto
inadeguato, e il tutto aveva un
aspetto decisamente poco invitante.
In complesso però, a parte l’assenza
del nonio del cerchio di declina-
zione, la montatura era completa di
tutte le sue componenti. Il prece-
dente proprietario aveva rimosso gli
anelli per l’attacco del tubo del tele-
scopio e aveva installato un sup-
porto artigianale per barra a coda di
rondine tipo Losmandy; inoltre la fi-
lettatura del contrappeso era stata
eliminata e vi era stata inserita una
manopola per bloccarlo. Peso com-
plessivo della montatura circa 60 kg.
Per prima cosa, dopo averla portata
S
i può far rinascere da un muc-
chio di rottami una gloriosa
montatura di 30 anni fa? Sì, si
può. Vi racconto la mia esperienza.
Circa due anni or sono, mentre cer-
cavo tutt’altro sul web, mi sono im-
battuto in una vecchia montatura
equatoriale Astro Italia in vendita.
Sono affettivamente legato a que-
sto tipo di strumenti in quanto mi ri-
cordano i tempi del mio ingresso nel
mondo astronomico
(primi anni '80), nonché
un telescopio che al-
l'epoca misi insieme e che
installai proprio sopra una
di quelle montature. Per
questi motivi ho deciso di
acquistarla e di intrapren-
derne il restauro.
Può essere utile per i let-
tori più giovani sapere che
le montature Astro Italia
erano prodotte da una
ditta romana in tre diversi
modelli: la “Standard T”,
di tipo “tedesco” o “a
sbalzo”, dotata di corona
dentata e vite senza fine
sull’asse orario e di brac-
cetto tangente per i movimenti fini
in declinazione; la “Professional T”,
anch’essa alla tedesca, che aveva
corona dentata e vite sia in A.R. sia
in declinazione; infine un terzo
modello a forcella. Tutte venivano
fornite su treppiede o colonna con
tre razze a 120° e viti calanti, ed
eventualmente con variatore di fre-
quenza e pulsantiera.
Sicuramente molto poco portatili
per il loro ingombro e per il loro
peso, non particolarmente economi-
che (io pagai la mia quasi 3 milioni
di lire nel 1984), queste montature,
così come quelle prodotte nello
stesso periodo da altri noti artigiani
(Urania, Spada, Marcon etc.) erano
considerate montature “serie”, al-
meno rispetto a quelle decisamente
più esili di cui erano dotati gli stru-
menti amatoriali maggiormente dif-
I
l blocco asse A.R. / asse declinazione
dopo il restauro.